Scienziati tra scienza ed etica
- ildisarmantejozef
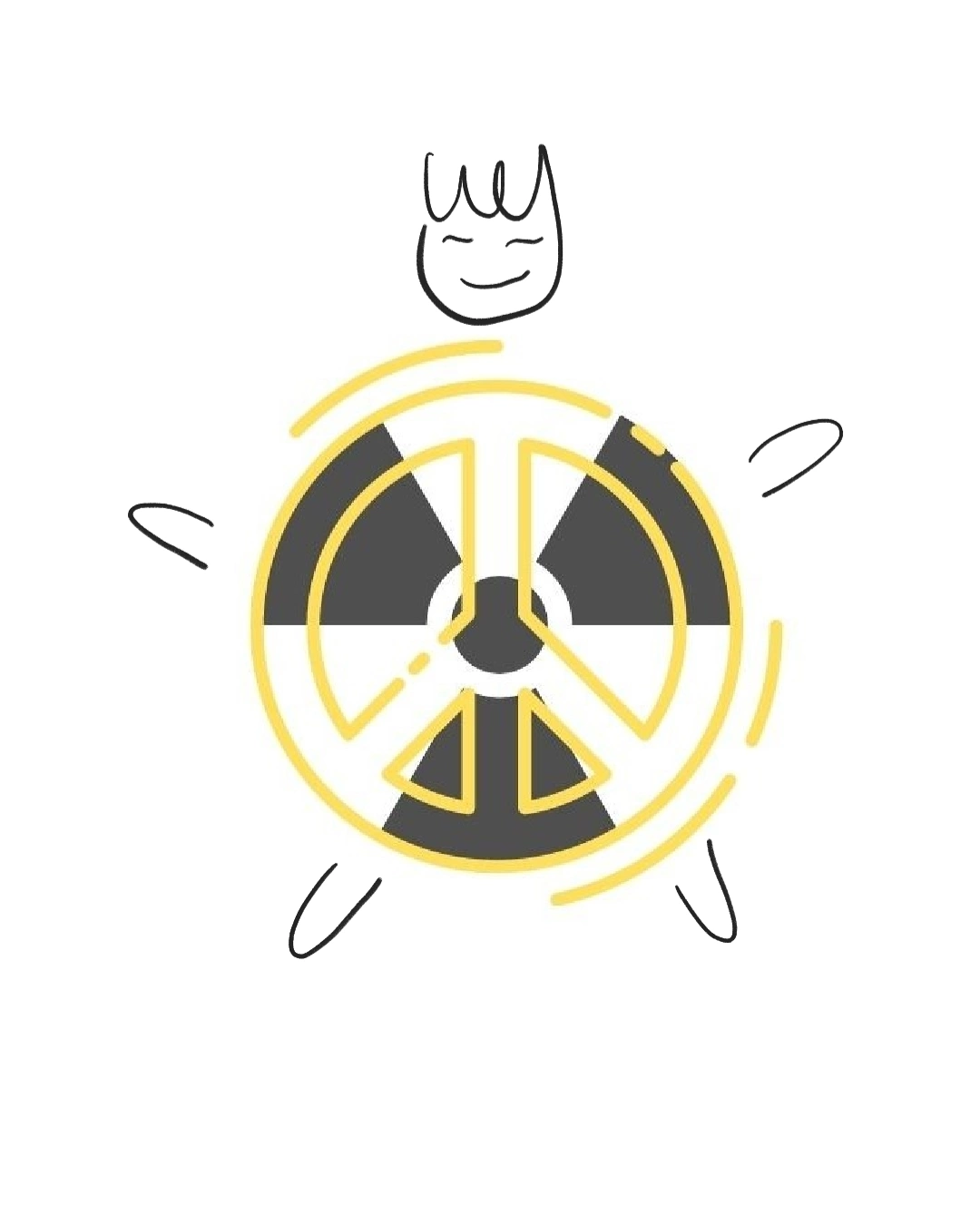
- 26 ago 2021
- Tempo di lettura: 9 min
Dopo lo scoppio delle bombe su Hiroshima e Nagasaki gli scienziati assumono posizioni diverse. È importante considerare il contesto storico in cui agirono per comprendere le loro reazioni. Di seguito sono analizzati i comportamenti delle personalità più importanti del periodo e che ebbero un ruolo attivo nella costruzione della bomba atomica.

Albert Einstein
Il 9 luglio del 1955 Einstein scrisse, assieme a Bertrand Russell, un manifesto sulla minaccia delle armi nucleari per il genere umano. I due studiosi volevano sollecitare gli altri scienziati e i politici a pensare in una nuova ottica mettendo in evidenza quelle che sono le conseguenze dell’esplosione di una bomba H, ancora più potente di quella sperimentata su Hiroshima e Nagasaki. Cercano di mettere in luce come una futura guerra combattuta con le armi nucleari, o con le bombe H, porrebbe fine all’umanità stessa. Il manifesto si conclude con queste parole: “Questa è allora la domanda che vi facciamo, rigida, terrificante, inevitabile: metteremo fine alla razza umana, o l’umanità rinuncerà alla guerra?”. Il manifesto venne poi firmato da altri illustri autori del periodo tra i quali troviamo: Max Born Perry, Williams Bridgman, Leopold Infeld, Frederic Joliot‐Curie, Herman Muller, Linus Pauling, Cecil Powell, Joseph Rotblat e Hideki Yukawa.
Dopo l’esplosione delle bombe nucleari in Giappone, Einstein si scambiò delle lettere con l’amico Seiei Shinohara, filosofo pacifista giapponese, sulla responsabilità dello scienziato tedesco. Nel gennaio del 1953, Shinohara scrisse ad Einstein chiedendogli: “Tu dici di essere un pacifista, ma perché allora hai appoggiato lo sviluppo della bomba atomica?”[1]. Einstein rispose che sarebbe stato giusto e necessario usare la bomba contro la Germania nazista, poiché quando il nemico minaccia la tua sopravvivenza il ricorso alla forza è inevitabile, ma anche che aveva sempre considerato un crimine l’esplosione su Hiroshima e Nagasaki. Einstein prosegue affermando: “condanno totalmente il ricorso alla bomba atomica contro il Giappone, ma non ho potuto fare niente per impedirlo”[2]. Lo scienziato tedesco ammette anche che l’unica consolazione che aveva era che l’uomo aveva visto cosa le bombe nucleari erano in grado di fare e che questo poteva avere una forza dissuasiva in futuro.
La visione etica di Einstein sulla costruzione della bomba si suddivide in tre periodi: tra il 1914 e il 1932 fu un grande sostenitore del pacifismo radicale, tra il 1933 e il 1945 si autodefinì un “pacifista sospeso” dal momento che “contro Hitler e il Nazismo non c’è altro modo per opporsi” e infine, da 1945 diventò un pacifista attivo e si impegnò per il disarmo nucleare.
Nel libro Pensieri degli anni difficili, Einstein disse: “non mi considero il padre dell’energia atomica” e affermò anche che non credeva che sarebbe stata costruita una bomba nucleare prima della sua morte. Nello stesso scritto, fa un paragone tra i fisici del suo tempo, quelli del 1945, e Alfred Nobel che per espiare alla creazione dell’esplosivo creò i premi Nobel per la pace a dimostrazione di come i fisici siano tormentati da un senso di responsabilità e di colpa. Einstein riteneva che fosse necessario mettere in guardia e informare tutti i governi del potenziale distruttivo della nuova arma poiché, nella sua visione, i fisici sanno cose che i politici non conoscono e riescono a comprendere più di tutti il fenomeno e l’urgenza che questo venga risolto. È loro compito renderne tutti consapevoli della minaccia. Inoltre, Einstein afferma che “per lo scienziato esiste solo l’essere: non il desiderio, il valore, il bene, il male, l’aspirazione (e che) le proposizioni scientifiche non possono produrre delle istanze etiche”[3].

Leo Szilard
Leo Szilard fu a capo della divisione di metallurgia del progetto Manhattan e si schierò contro l’uso della bomba atomica sul Giappone. Nel marzo del 1945 scrisse un memorandum in cui affermava che la bomba nucleare sarebbe stata “un grave errore”[4] e fece circolare alcune petizioni per l’abolizione della bomba atomica. Inoltre, nel 1946 fondò assieme ad Einstein un Comitato di Emergenza degli Scienziati Atomici. Nel 1950, infine, si oppose allo sviluppo della bomba H.
Quando scoppio la bomba su Hiroshima, Szilard commentò con queste parole: “abbiamo creato uno strumento che può distruggerci tutti, e di questo siamo tutti colpevoli. È nostro dovere far sì che questo non accada mai, come uomini e come scienziati”[5]. Szilard si sentì responsabile di aver sollecitato Roosevelt ad avviare il programma nucleare e da quel momento si dedicò alla lotta contro l’utilizzo delle armi nucleari.

J. Robert Oppenheimer
Oppenheimer fu il leader scientifico del progetto e lo scienziato che più di tutti mostrò le contraddizioni di un uomo di scienza diviso tra la sete di conoscenza e i dubbi etici e morali dell’impiego del nucleare. Egli scelse, non solo di battersi affinché l’opinione pubblica fosse informata sul potenziale distruttivo della bomba atomica, ma si oppose fortemente alla costruzione della bomba H e lottò per il disarmo nucleare, anche a costo di rischiare la sua carriera e di venir espulso dalla comunità scientifica. “Sono diventato Morte, distruttore di mondi”[6], così il capo del progetto Manhattan commentò il test della bomba nucleare del 16 luglio 1945 a Alamogordo, in Nuovo Messico, mentre Kenneth Bainbridge, direttore del test, commentò dicendo: “Nessuno che l’abbia visto potrà dimenticare quel laido e terribile spettacolo. Ora siamo tutti figli di puttana”[7]. Nonostante questo, era a favore dell’uso della bomba nucleare sul Giappone ma quando nel 1946 incontrò il presidente Truman disse “Presidente ho le mani sporche di sangue”[8]. Da quel momento Oppenheimer cercò in tutti i modi di opporsi alle armi nucleari e partecipò a numerose iniziative per la denuclearizzazione. Si oppose alla costruzione della Bomba H, ritenendo che questa non avrebbe risolto i problemi strategici americani ma che avrebbe solo abbassato il livello etico del paese. Questa visione era in contrasto con quella di altri scienziati, primo tra tutti Teller, e uomini politici, come Joseph McCarthy, e nel 1954 venne avviata un’inchiesta che gli negò l’accesso ai segreti militari nucleari, poiché in passato aveva manifestato simpatie comuniste. La comunità scientifica, guidata da Einstein, insorse e gli Stati Uniti nel 1963 gli conferirono il premio Enrico Fermi riabilitando il suo nome.
Dopo aver abbandonato Los Alamos, Oppenheimer approfondì il problema della crisi etica della scienza che stava affrontando personalmente. In un discorso ai membri della Association of Los Alamos Scientist, il 2 novembre del 1945, lo scienziato americano disse: “è una crisi molto grave che non si potrà eludere con soluzioni di comodo e semplificazioni: né con la promessa dei benefici che l’energia atomica porterà all’umanità”[9]. Oppenheimer ammise di sentire un senso di responsabilità personale molto forte ma anche il dovere di diffondere le informazioni sulla bomba, anche violando il segreto militare. Il 25 novembre del 1947 all’istituto di tecnologia del Massachusetts durante una conferenza disse: “per aver minuziosamente suggerito, appoggiato e, infine, realizzato la costruzione delle armi atomiche, i fisici conobbero il peccato; e questa è una conoscenza che rimarrà in loro per sempre”[10].

Enrico Fermi
Nel dicembre del 1942 Fermi ottenne a Chicago la prima pila atomica e partecipò al progetto Manhattan esprimendosi, come Oppenheimer, a favore dell’uso della bomba contro il Giappone. Successivamente, si schierò contro la costruzione e l’uso della bomba H.
Ventidue giorni dopo lo scoppio della bomba nucleare su Hiroshima, il 28 agosto 1945, Fermi descrisse il suo lavoro a Los Alamos, in una lettera all’amico Amaldi, con queste parole: “è stato un lavoro di notevole interesse scientifico e l'aver contribuito a troncare una guerra che minacciava di tirar avanti per mesi o per anni è stato indubbiamente motivo di una certa soddisfazione. Noi tutti speriamo che l'uso futuro di queste nuove invenzioni sia su una base ragionevole e serva a qualche cosa di meglio che a rendere le relazioni internazionali ancora più difficili di quello che sono state fino ad ora”[11]. Da queste parole deduciamo che Fermi non si pentì di aver partecipato al progetto e di aver consigliato di usare le bombe sul Giappone ma anzi, spera che in futuro la scoperta possa essere usata “ragionevolmente”.

Edward Teller
Edward Teller fu un fisico ungherese e leader del progetto di costruzione della bomba H. Teller oggi rappresenta la scienza non responsabile: sosteneva che “non si può e non si deve arrestare il progresso della scienza pura e applicata”[12]. Teller fu l’esempio dello scienziato senza dubbi che scelse sempre senza ambiguità la "zona nera". Inoltre, Teller credeva che gli Stati Uniti si dovessero affermare come potenza leader in campo internazionale grazie alle armi nucleari, infatti si rifiutò di firmare la seconda petizione di Szilard contro la bomba atomica. La posizione di Teller è riassunta in una lettera indirizzata allo stesso Leo Szilard: “prima di tutto permettimi di dire che non ho speranza di pulire la mia coscienza. Le cose sulle quali stiamo lavorando sono così orribili che nessuna protesta né maneggio con i politici salverà le nostre anime. Non ho lavorato a questo progetto per ragioni egoistiche e mi ha prodotto molti più fastidi che piaceri. Ho lavorato perché il problema mi ha interessato ed avrei considerato una grossa limitazione non andare avanti. Non dico di avere fatto il mio dovere. Il senso del dovere mi avrebbe potuto tenere fuori di questo lavoro. Non avrebbe potuto tenermi fuori di questo lavoro contro le mie inclinazioni. Se riesci a convincermi che le tue obiezioni morali sono valide, io abbandono il lavoro. Ho difficoltà a pensare che dovrei cominciare a protestare. Il fatto casuale che noi siamo riusciti a produrre questo orribile oggetto non deve darci la responsabilità di avere voce nel modo con il quale deve essere usato. Questa responsabilità deve in conclusione essere delegata al popolo come un tutto e questo può essere fatto solo facendo sì che il popolo conosca i fatti. Questa è la sola causa per la quale mi sento autorizzato a fare qualcosa: la necessità di togliere il segreto per lo meno sui temi più generali del nostro lavoro. A quanto ho capito questo sarà fatto appena la situazione militare lo permetterà”[13]. Da queste righe comprendiamo come Teller non si sentì responsabile per aver partecipato alla creazione della bomba ma, anzi, ritenne che la responsabilità del suo utilizzo fosse del popolo.

Franco Rasetti
Franco Rasetti fu invitato a partecipare al progetto Manhattan ma ritenne che lo scienziato non si dovesse impegnare nella progettazione di armi e criticò duramente l’operato del suo collega Fermi. Rasetti rigettò con decisione l’idea che la scienza fosse neutrale e per lui la responsabilità dello scienziato in campo etico e morale venne prima della ricerca e della “sete di conoscenza”.
Quando gli venne chiesto di partecipare al progetto Manhattan rispose che “la fisica non può vendere l’anima al diavolo”[14]. Nell’immediato dopo guerra Rasetti scrisse una lettera a Enrico Persico in cui spiega la sua posizione: “sono rimasto talmente disgustato dalle ultime applicazioni della fisica (con cui, se Dio vuole, sono riuscito a non aver niente a che fare) che penso seriamente a non occuparmi più che di geologia e biologia. Non solo trovo mostruoso l'uso che si è fatto e che si sta facendo delle applicazioni della fisica, ma per di più la situazione attuale rende impossibile rendere a questa scienza quel carattere libero e internazionale che aveva una volta e la rende soltanto un mezzo di oppressione politica e militare. Pare quasi impossibile che persone che una volta consideravo dotate di un senso della dignità umana si prestino a essere lo strumento di queste mostruose degenerazioni. Eppure, è proprio così e sembra che neppure se ne accorgano. Tra tutti gli spettacoli disgustosi di questi tempi ce ne sono pochi che eguaglino quello dei fisici che lavorano nei laboratori sotto la sorveglianza militare per preparare mezzi più violenti di distruzione per la prossima guerra"[15]. In questa lettera Rasetti si riferisce in particolare al collega Fermi con cui aveva lavorato nel laboratorio di Via Panisperna. Il fatto di non aver partecipato alla costruzione della bomba non lo fece, però, sentire del tutto innocente, per tutta la sua vita Rasetti si sentì responsabile di aver partecipato alla scoperta del meccanismo su cui si basava la bomba nucleare.

Werner Heisenberg
Quando Hitler prese il potere il fisico tedesco si trovò davanti ad una scelta: scappare dalla Germina, come aveva fatto Einstein, o rimanere, come aveva fatto Planck. Heisenberg decise di rimanere e fu tra i più importanti scienziati che parteciparono alle ricerche nucleari naziste. Si ritiene che lo fece sia per patriottismo che per difendere il prestigio della fisica teorica tedesca. Ancora oggi gli storici si chiedono se effettivamente Heisenberg non riuscì a costruire una bomba o se fece il possibile per boicottarla. Nel 1942 incontrò Bohr in Danimarca, e lo scienziato danese ebbe l’impressione che Heisenberg volesse costruire una bomba o un reattore. Preoccupato e convinto che la Germania fosse vicina alla scoperta delle armi nucleari si rifugiò negli Stati Uniti.
Nel 1973 Heisenberg fece un discorso all’Accademia Cattolica di Baviera dove ricorda che “la scienza può essere usata per elaborare armi con la più atroce capacità distruttiva”[16].

Jozef Rotblat
Quando fu evidente l’impossibilità per i tedeschi di costruire la bomba atomica Rotblat abbandonò il progetto Manhattan, fu l’unico a farlo prima dello scoppio della bomba, e firmò il manifesto di Russel ed Einstein. Nel 1957 fondò la Pugwash Conference la più importante organizzazione composta da scienziati per l’abolizione delle armi nucleari e nel 1955 fu insignito per il premio Nobel per la pace. Rotblat è un esempio di come ogni scienziato avesse la possibilità di scegliere di tirarsi indietro dal progetto ed egli, agendo secondo la sua morale, scelse di dedicarsi alla pace e non alla costruzione di armi.
[1] Mascheroni L., Ed Einstein confessò: “non ho potuto far nulla per fermare l’atomica”, in “Il giornale”, 4 luglio 2005 <http://www.ilgiornale.it/news/ed-einstein-confess-non-ho-potuto-far-nulla-fermare-l.html> [2] Ibidem. [3] Einstein A., Pensieri degli anni difficili, Boringhieri, Torino, 1965, p. 249. [4] Bonolis L., Storia della bomba atomica, quando la fisica andò alla guerra, in “Galileonet”, 1° luglio 2005 <https://www.galileonet.it/storia-bomba-atomica-energia-nucleare/> [5] Greco P., Hiroshima: la fisica conosce il peccato, 1995, p.33. [6] Bonolis L., Storia della bomba atomica, quando la fisica andò alla guerra, cit. [7] Ibidem. [8] Zucchetti M., L’ingegneria nucleare e l’atomica: un percorso etico, conferenza di Storia dell’Ingegneria, in “Atti del III convegno nazionale”, Napoli, 19-21 aprile 2019, p. 972. [9] Cioci V., Oppenheimer e i nuovi interrogativi della scienza, cit., pp. C06.3. [10] Ivi, p. C06.4. [11] Motivazioni e ruolo di Fermi, in “Scienza e Scuola”
<http://www.scienzaatscuola.it/fermi/manhattan/fermi_bomba.html> [12] Russoniello A., Franco Rasetti: l’uomo che disse no alla bomba, in Per la pace, 8 agosto 2008 <http://www.perlapace.it/franco-rasetti-l-uomo-che-disse-no-alla-bomba/> [13] Vadacchino M., La morale degli scienziati e la bomba atomica, in “Docplayer”, p.7
<https://docplayer.it/19565134-La-morale-degli-scienziati-e-la-bomba-atomica-1-di-mario-vadacchino.html> [14] Russoniello A., Franco Rasetti: l’uomo che disse no alla bomba, cit. [15] Vadacchino M., La morale degli scienziati e la bomba atomica, cit., p.7. [16] Vita e pensiero di Werner Heisenberg, in “Filosofia e scienza”, 25 marzo 2017 <http://www.filosofiaescienza.it/vita-pensiero-werner-heisenberg/>




Comments